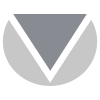Cosa rende i sandali tedeschi così universalmente di successo?
Forse qualcosa che ha a che fare più con il modo in cui definiamo noi stessi che con le scarpe.

I tempi in cui c’era bisogno di giustificarsi quando si indossava un paio di Birkenstock, a pensarci bene, nemmeno ce li ricordiamo. L’inizio della mia affezione nei confronti dei sandali tedeschi si potrebbe indicativamente collocare nel 2010, quando tornata dal mio anno a Colonia ero convinta fossero la prova inconfutabile della mia nuova raggiunta indipendenza (in potenza, si capisce), mentre ai più svegli di me sembravano quello che erano, e cioè la chiara riprova di una depressione post Erasmus. Eppure, quello che lega i portatori di Arizona o Gizeh ai loro sandali brutti è davvero qualcosa di molto personale, ché ormai sappiamo che dai nostri anni all’estero ci abbiamo ricavato perlopiù illusioni e, se non altro, l’attitudine a non lasciarsi sopraffare dalla burocrazia. I sandali, però, sono rimasti: vuoi perché sono e effettivamente comodi, una volta che il piede si abitua alla suola rigida, vuoi perché di lì a poco, nel tentativo di avviare una carriera nell’editoria, avrei assistito da vicino alla loro – ennesima – riabilitazione nel mondo del “fashion”, quella in chiave surrealista compiuta dall’impareggiabile Phoebe Philo.
La collezione Primavera-Estate 2013 di Céline, a riguardarla oggi, sembra foriera di profondi significati nascosti sull’andamento attuale dell’industria della moda. Intanto perché è ancora bella, e poi perché rivedendo le ciabatte pelose sdoganate da Philo a corollario di morbidi completi spezzati e abiti al ginocchio dai nodi intellettuali, si fa fatica a trovare qualcosa di fuori dall’ordinario, di strano. Quella che fino a non troppi anni fa rappresentava una nicchia del mercato, frequentata da consumatori raffinati idealmente attenti a cose come il taglio e le cuciture ma in realtà affamati anch’essi di etichette sociali come tutti gli altri, è ora anche un’estetica riconoscibile, radicata nell’immaginario collettivo perché a portata di tutti. Basta andare da Cos, d’altronde, o cercare la vetrina di Mango e/o Zara dedicata allo stile minimal-chic. Ancora meglio, basta guardarsi intorno, e scorgere fra i passanti un paio di Birkenstock.
E quella di Philo non è neanche la loro prima volta su una passerella importante: nel 1992, Marc Jacobs aveva le aveva usate nella sua collezione “grunge” per Perry Ellis. Ha ragione allora il Chief Marketing Officer Yvonne Piu quando mi dice che a rendere Birkenstock un marchio dal successo universale è proprio «l’autenticità. La nostra è una storia vera, reale. Abbiamo un’eredità alla quale siamo rimasti fedeli nel tempo». E i consumatori lo riconoscono. Oggi le scarpe del ciabattino registrato alla chiesa di Langen-Bergheim più di 240 anni fa sono vendute in 90 Paesi nel mondo, contano 37 punti vendita monomarca e 3.800 dipendenti nei nove stabilimenti attivi in Germania, distribuiti negli stati federati della Renania Settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Assia, Baviera e Sassonia. Oltre ai sandali, Birkenstock produce scarpe chiuse, da bambini e da lavoro, calze, borse e articoli ortopedici. Seguendo il principio della “funzione prima della forma” – o dell’amore “a seconda vista”, come la chiama spesso il Ceo Reichert – le ultime estensioni organiche del marchio contano una linea di letti «per sonni salutari, così come i nostri sandali sono ideati per la salute del piede», mi spiega Piu, e una linea cosmetica, Natural Skin Care, «cento per cento sostenibile e certificata. L’ingrediente principale di tutti i nostri prodotti è la suberina, derivante dal sughero. E si torna così al punto di partenza». In effetti, non fa una piega. Presentati in esclusiva durante l’edizione Pitti Uomo dello scorso gennaio, i letti facevano parte dell’esperienza olistica ricostruita da Birkenstock in uno spazio di 700 metri all’interno della Fortezza da Basso, dove tradizionalmente si svolge il salone fiorentino dedicato alla moda maschile. C’erano i sandali, certo, ma anche stivaletti e scarpe chiuse, accessori e, appunto, i cosmetici.
«A rendere Birkestock un marchio dal successo universale è l’autenticità.
La nostra è una storia vera, reale. Abbiamo un’eredità alla quale siamo rimasti fedeli nel tempo»
Nell’estate del 2017, d’altronde, Birkenstock aveva già segnato due traguardi storici: la sua prima sfilata a Parigi, con una collezione di abbigliamento disegnata da un team interno e presentata nel Giardino delle Tuileries, e l’inaugurazione di un nuovo modello itinerante di negozio, la Birkenstock Box, realizzata in collaborazione con lo studio d’architettura Gonzalez Haase AAS. La Box ha debuttato da Andreas Murkudis a luglio, concept store epitome del cool berlinese, per poi girare il mondo, passando da 10 Corso Como a Milano a Kirna Zabête negli Hamptons. L’ultima installazione ha inaugurato lo scorso aprile su La Brea Avenue a Los Angeles per opera di Rick Owens. Una collaborazione che potrebbe sembrare azzardata, ma che Piu definisce naturale: «Oltre all’elemento avant-garde, di grande rilievo nella sua moda, quello di Owens è un business di famiglia, i cui prodotti richiedono un alto livello di artigianalità e una specializzazione nella lavorazione della pelle. E questi sono solo alcuni dei tratti comuni a Birkenstock». Ragionamento ineccepibile, considerando che gli intrepidi sandali vengono sottoposti a 17 diverse fasi di produzione e, almeno nella versione ironica quel che basta ridisegnata da Owens, arriveranno a costare quasi 300 euro. «Non ho voluto farci chissà cosa» ha spiegato lo stilista a Vogue «Ho voluto lavorare sull’architettura della scarpa, così ho allungato le fibbie in modo che toccassero terra e ci ho aggiunto dei buchi, perché quando aggiungi dei buchi quelli diventano qualcosa di più, quasi fossero pizzo. Aggiungere dei buchi ingentilisce subito qualcosa». Il 13 giugno Birkenstock è tornato a Pitti Uomo, questa volta al Giardino Torrigiani, con una sfilata-evento per la collezione per la Primavera-Estate 2019 che comprende tutte le categorie di prodotto.

«Generalmente non prestiamo molta attenzione a qual è l’ultima tendenza nella moda.
A essere onesti, sarebbe meglio non essere poi così tanto di moda, ora come ora».
Ma quando è stato, esattamente, che ci siamo innamorati dell’autenticità? Una risposta ha provato a darla Andrew Potter sull’ultimo numero di Vestoj Magazine, interamente dedicato al tema dell’autentico nella moda, nel suo saggio “Autenthicity is a con”, prendendo spunto dalla Teoria della classe agiata di Thorstein Veblen, uscito per la prima volta nel 1899, secondo cui all’origine di ogni forma di proprietà c’è il desiderio (o meglio l’invidia) per la ricchezza altrui, che a sua volta, seguendo il principio che Veblen chiama cumulabilità dell’emulazione, scatena il cosiddetto “consumo ostentativo”. Potter teorizza, invece, “l’autenticità ostentativa”: cosa distingue ciò che è autentico da ciò che non lo è? È la domanda che oggi ci facciamo quando compriamo qualcosa, il fondamento ultimo del consumismo responsabile, che va a cercare «la differenza tra ciò che è cool e ciò che è copiato, tra il sincero e lo svenduto, tra il genuino e il fake». L’errore di fondo, dice Potter, è stato pensare per tutto questo tempo alle controculture come a qualcosa fuori dal sistema: non lo erano per nulla, e sono bastati Mtv, internet e soprattutto i social media a dimostrarlo. Se il cool può arrivare all’istante nei più remoti angoli del globo, privandoci così dell’etichetta sociale che tanto faticosamente abbiamo cercato per attaccarcela al petto, non ci rimane che l’autentico, ultimo baluardo dell’individualismo da nicchia riflessiva, o classe intellettuale, per chi bada alle nomenclature.
Peccato che da Birkenstock se ne infischino, anzi se possibile ne siano anche un po’ infastiditi. Lo spiegava Reicher al New Yorker nel sopracitato articolo, che questa cosa di impazzire tutti per un determinato modello in un determinato periodo – prendi le Arizona bianche, perfette per le foto dall’alto su Instagram – a loro non è piaciuta per nulla, quasi quasi andava in tilt la produzione, mica ci si comporta così. «Generalmente non prestiamo molta attenzione a qual è l’ultima tendenza nella moda. A essere onesti, sarebbe meglio non essere poi così tanto di moda, ora come ora», ha detto. Come a dire, ne abbiamo di strada da fare, meno male che le scarpe sono comode.
Fotografie di Studio BDG
Dal numero 35 di Studio, in edicola
Fonte : http://www.rivistastudio.com/long-form/birkenstock-storia/